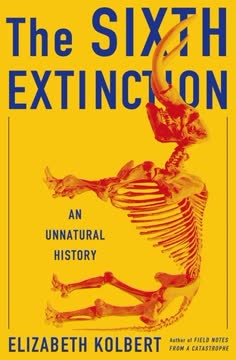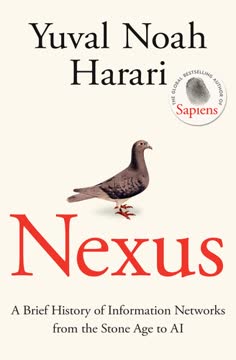Punti chiave
1. Le società collassano quando i problemi ambientali le sopraffanno.
Per collasso intendo una drastica diminuzione della popolazione umana e/o della complessità politica, economica e sociale, su un’area considerevole e per un periodo prolungato.
Limiti ambientali. Molte società del passato, dall’Isola di Pasqua ai Maya, hanno raggiunto picchi di popolazione e complessità per poi declinare o scomparire. Questo collasso è spesso avvenuto perché hanno involontariamente distrutto le risorse ambientali da cui dipendevano: foreste, suolo, acqua e fonti alimentari selvatiche.
Ecocidio. Il processo di suicidio ecologico involontario, o ecocidio, comprendeva pratiche come la deforestazione, l’erosione del suolo, la salinizzazione, la cattiva gestione delle acque, la caccia e la pesca eccessive. Con l’aumento della popolazione, l’uso delle risorse si intensificava e si espandeva su terreni marginali, causando danni ambientali che la terra non poteva sostenere.
Conseguenze. Il risultato erano carenze alimentari, carestie e una crescente competizione per risorse sempre più scarse. Questo spesso portava a conflitti interni, guerre e al rovesciamento delle élite al potere da parte delle masse deluse. La popolazione diminuiva drasticamente per morte o emigrazione, e le società perdevano la loro complessità politica, economica e culturale.
2. Il collasso raramente è semplice, ma frutto dell’interazione di molteplici fattori.
Non conosco alcun caso in cui il collasso di una società possa essere attribuito esclusivamente a danni ambientali: ci sono sempre altri fattori che contribuiscono.
Schema a cinque punti. Per comprendere il collasso sociale è necessario considerare molteplici fattori interagenti, non solo il danno ambientale. Un quadro utile include:
- Danno ambientale (auto-inflitto)
- Cambiamenti climatici (naturali o causati dall’uomo)
- Vicini ostili
- Partner commerciali amichevoli (perdita di supporto)
- Risposta della società ai propri problemi
Interconnessione. Questi fattori spesso si aggravano a vicenda. Una società che esaurisce le proprie risorse può sopravvivere a un clima benigno, ma essere spinta al limite da siccità o freddo. Indebolita dallo stress ambientale, diventa vulnerabile a vicini ostili o alla perdita di sostegno da parte di partner commerciali in difficoltà.
Esiti complessi. Diverse società collassano in modi e gradi differenti, a seconda della combinazione e della gravità di questi fattori. Alcune, come l’Unione Sovietica o l’antica Cartagine, sono crollate principalmente per ragioni non ambientali, dimostrando che il danno ambientale non è una causa universale di collasso.
3. La fragilità ambientale rende le società più vulnerabili al collasso.
Per l’Isola di Pasqua, più che per qualsiasi altra società trattata in questo libro, possiamo specificare in dettaglio i fattori alla base della fragilità ambientale.
Resilienza variabile. Gli ambienti differiscono molto nella capacità di resistere all’impatto umano e di recuperare dai danni. Gli ambienti fragili, come quelli dell’Isola di Pasqua o dell’Islanda, sono più suscettibili al degrado rispetto a quelli robusti.
Fattori di fragilità. La fragilità ambientale dipende da diverse caratteristiche:
- Clima (climi secchi, freddi o imprevedibili ostacolano la crescita e il recupero delle piante)
- Tipo di suolo (suoli leggeri, sottili o poveri di nutrienti si erodono facilmente e si formano lentamente)
- Attività geologica (la mancanza di vulcanismo recente o sollevamento riduce il rinnovo del suolo)
- Isolamento (limita l’accesso a risorse esterne per il recupero)
Esiti differenziati. Le società in ambienti fragili, anche con livelli simili di impatto umano, sono più propense a subire conseguenze gravi rispetto a quelle in ambienti resilienti. L’estrema deforestazione dell’Isola di Pasqua è stata in parte dovuta al suo ambiente unicamente fragile, mentre le difficoltà dell’Islanda erano legate ai suoi suoli vulcanici sensibili.
4. Il cambiamento climatico è una minaccia ricorrente che interagisce con l’impatto umano.
Non è stato un singolo fattore preso da solo, ma la combinazione di impatto ambientale e cambiamento climatico a risultare fatale.
Fluttuazioni naturali. Il clima è sempre variato naturalmente, diventando più caldo o freddo, più umido o secco, o più variabile nel tempo. Le società passate, spesso senza registrazioni scritte o memoria a lungo termine, erano vulnerabili a cambiamenti climatici di più decenni come siccità o periodi freddi.
Aggravamento di problemi esistenti. Il cambiamento climatico agisce spesso come fattore di stress su società già indebolite da danni ambientali auto-inflitti. Gli Anasazi e i Maya, per esempio, affrontavano già problemi di deforestazione e crescita demografica quando siccità severe li spinsero verso il collasso.
Effetti differenziati. Il cambiamento climatico può avvantaggiare una società e danneggiarne un’altra, a seconda della loro posizione e stile di vita. La Piccola Era Glaciale fu dannosa per i Norreni in Groenlandia ma benefica per gli Inuit, meglio adattati al freddo e al ghiaccio marino.
5. Le relazioni con i vicini (commercio e conflitto) sono cruciali per la sopravvivenza.
Da qui nasce il rischio che, se il tuo partner commerciale si indebolisce per qualsiasi motivo (incluso il danno ambientale) e non può più fornire l’importazione essenziale o il legame culturale, la tua stessa società possa indebolirsi di conseguenza.
Interdipendenza. La maggior parte delle società non è isolata, ma interagisce con i vicini tramite commercio e conflitti. La dipendenza da partner commerciali amichevoli per risorse essenziali o legami culturali crea vulnerabilità se questi partner declinano.
Perdita di supporto. Il collasso delle isole Pitcairn e Henderson fu scatenato dal declino ambientale e dall’incapacità del loro partner commerciale, Mangareva, di continuare a fornire importazioni essenziali come utensili in pietra e cibo. Analogamente, il declino del commercio con la Norvegia contribuì alla fine dei Norreni in Groenlandia.
Interazioni ostili. Le società indebolite da problemi ambientali o climatici diventano più suscettibili ad attacchi da vicini ostili. La caduta dell’Impero Romano d’Occidente, dell’Impero Khmer e dei Norreni in Groenlandia fu influenzata dalle azioni di gruppi vicini, il cui successo era spesso legato al declino della società in collasso.
6. La risposta di una società ai propri problemi determina il suo destino.
Diverse società rispondono in modo differente a problemi simili.
La scelta conta. Anche di fronte a sfide ambientali simili, le società prendono decisioni diverse su come reagire. Queste risposte sono plasmate dalle istituzioni e dai valori politici, economici, sociali e culturali.
Vie al successo. Le società possono avere successo con approcci diversi:
- Dal basso verso l’alto: comunità locali gestiscono le risorse basandosi su conoscenze e interessi condivisi (es. abitanti delle alture della Nuova Guinea, Tikopia).
- Dall’alto verso il basso: governi centralizzati attuano politiche per il bene a lungo termine dell’intera società (es. Giappone Tokugawa, Impero Inca).
Mancata adattabilità. Le società che falliscono spesso si aggrappano a valori o pratiche non più adatti alle circostanze in cambiamento. I Norreni in Groenlandia, per esempio, furono riluttanti ad adottare tecnologie inuit o a modificare il loro stile di vita, contribuendo alla loro fine.
7. Le società non risolvono i problemi per ragioni prevedibili.
Come può una società non aver visto per tempo i pericoli che a noi appaiono così evidenti a posteriori?
Molteplici punti di fallimento. Le società possono fallire nel risolvere problemi in diverse fasi:
- Mancata anticipazione: assenza di esperienza precedente o dimenticanza di eventi passati.
- Mancata percezione: problemi impercettibili, dirigenti distanti o tendenze lente mascherate da fluttuazioni (normalità strisciante, amnesia del paesaggio).
- Mancato tentativo di risolvere: conflitti razionali di interesse (tragedia dei beni comuni, élite contro masse) o comportamenti irrazionali (valori, negazione, pensiero di gruppo).
- Mancato successo: problema troppo difficile, soluzione troppo costosa o sforzi troppo pochi e tardivi.
Natura umana. Questi fallimenti derivano da tratti umani comuni e dinamiche organizzative. Egoismo, pensiero a breve termine, resistenza al cambiamento e bias psicologici possono impedire azioni efficaci anche quando i problemi sono riconosciuti.
Lezioni dal fallimento. Capire perché le società falliscono è fondamentale per aumentare le nostre possibilità di successo. Identificando queste trappole comuni, possiamo sviluppare strategie per evitarle e migliorare i processi decisionali collettivi.
8. Comportamenti razionali e irrazionali guidano decisioni disastrose.
Contrariamente a quanto Joseph Tainter e quasi tutti si aspettavano, spesso le società non tentano nemmeno di risolvere un problema una volta che lo hanno percepito.
Comportamento razionale dannoso. Individui o gruppi possono agire in modi dannosi per altri o per la società se percepiscono correttamente che ciò avanza i propri interessi. Questo comportamento “razionale” è comune in affari e politica, specialmente quando i profitti sono concentrati in pochi mentre i costi sono diffusi tra molti (sussidi perversi).
Comportamento irrazionale. Le società falliscono anche a causa di comportamenti dannosi per tutti, spesso guidati da valori profondamente radicati o bias psicologici. Esempi includono:
- Attaccamento a valori ormai insensati (es. credenze religiose, stili di vita tradizionali).
- Effetto sunk cost (riluttanza ad abbandonare politiche fallite).
- Negazione psicologica (ignorare realtà dolorose).
- Pensiero di gruppo o psicologia della folla (soppressione del dissenso per consenso).
Conflitto di interessi. I fallimenti spesso nascono da conflitti tra interessi a breve termine delle élite decisionali e interessi a lungo termine del resto della società. Le élite possono essere isolate dalle conseguenze delle loro azioni, portandole a privilegiare il guadagno personale rispetto al benessere collettivo.
9. Il comportamento ambientale delle grandi imprese è plasmato da pressioni esterne.
A lungo termine, è il pubblico, direttamente o tramite i suoi politici, che ha il potere di rendere le politiche ambientali distruttive non redditizie e illegali, e di rendere redditizie quelle sostenibili.
Motivazione del profitto. Le imprese sono guidate principalmente dalla necessità di generare profitti per gli azionisti. Alcune pratiche ambientali possono essere redditizie (es. evitare disastri costosi, ottenere vantaggi competitivi), altre no, almeno nel breve termine.
Forze esterne. Il comportamento ambientale delle imprese è fortemente influenzato da pressioni esterne:
- Regolamentazioni governative e loro applicazione (es. estrazione del carbone vs. minerali duri).
- Opinione pubblica e preferenze dei consumatori (es. domanda di legname e pesce sostenibili).
- Azioni degli acquirenti nella catena di fornitura (es. DuPont e Tiffany che influenzano pratiche minerarie).
- Morale e valori dei dipendenti.
Responsabilità pubblica. In ultima analisi, il pubblico detiene il potere di influenzare il comportamento delle imprese chiedendo pratiche migliori attraverso scelte di acquisto, azione politica e sfide legali. Quando il pubblico tollera pratiche distruttive, le imprese sono più propense a perseguirle.
10. I problemi ambientali moderni sono globali, interconnessi e in accelerazione.
Per la prima volta nella storia, affrontiamo il rischio di un declino globale.
Dodici problemi. Le società moderne affrontano una dozzina di grandi problemi ambientali, otto ereditati dal passato e quattro nuovi:
- Distruzione/perdita di risorse: habitat, cibo selvatico, biodiversità, suolo.
- Limiti alle risorse: energia, acqua dolce, capacità fotosintetica.
- Emissioni dannose: sostanze chimiche tossiche, specie aliene, cambiamenti atmosferici.
- Problemi demografici: numero di abitanti, impatto pro capite.
Interconnessioni. Questi problemi sono profondamente interconnessi; la crescita demografica aggrava tutti gli altri, l’uso di energia contribuisce ai cambiamenti atmosferici e all’inquinamento, e l’esaurimento delle risorse aumenta la competizione e il conflitto. Risolvere un problema spesso dipende dal risolvere gli altri.
Ritmo accelerato. Il degrado ambientale accelera a causa dell’aumento della popolazione e dell’impatto pro capite. Molti problemi, come la deforestazione, il collasso delle pesca e l’esaurimento dei combustibili fossili, hanno tempi di esaurimento inferiori a 50 anni, minacciando cambiamenti significativi nello stile di vita entro la vita della generazione attuale.
11. La speranza risiede nel riconoscere i problemi e fare scelte coraggiose.
Riflettendo profondamente sulle cause dei fallimenti passati, anche noi, come il presidente Kennedy nel 1961 e 1962, potremmo riuscire a correggere la rotta e aumentare le nostre possibilità di successo futuro.
Non è inevitabile. Il collasso sociale non è predeterminato. Pur esistendo sfide ambientali, il destino di una società dipende dalle sue scelte e risposte. Storie di successo come il Giappone Tokugawa e Tikopia dimostrano che pratiche sostenibili sono possibili.
Imparare dal passato. Studiare fallimenti e successi passati offre lezioni preziose, ma il contesto moderno è unico per la globalizzazione, la tecnologia avanzata e la scala dei problemi. Affrontiamo rischi globali ma anche opportunità senza precedenti di apprendere dagli altri.
Leadership coraggiosa. Risolvere i problemi moderni richiede leader coraggiosi e pubblici disposti a:
- Anticipare e percepire i problemi precocemente.
- Dare priorità al benessere a lungo termine rispetto al guadagno immediato.
- Rivalutare valori fondamentali che potrebbero non favorire più la sopravvivenza.
- Attuare soluzioni audaci ed efficaci (dall’alto e dal basso).
Empowerment. Riconoscere la responsabilità ultima del pubblico nel plasmare il comportamento di imprese e governi è fonte di potere. Chiedendo pratiche sostenibili e sostenendo leader coraggiosi, possiamo aumentare le nostre possibilità di affrontare le sfide attuali e costruire un futuro sostenibile.
Ultimo aggiornamento:
Recensioni
Crollo suscita opinioni contrastanti. Molti apprezzano l’analisi di Diamond sui collassi storici delle società dovuti a fattori ambientali, trovando particolarmente convincenti gli esempi dell’Isola di Pasqua e della Groenlandia norrena. I lettori riconoscono il valore delle riflessioni sull’importanza della sostenibilità e della gestione delle risorse. Tuttavia, alcuni criticano la ripetitività degli argomenti e ritengono meno coinvolgenti gli esempi moderni. I detrattori sostengono che Diamond semplifichi eccessivamente eventi storici complessi, trascurando fattori non ambientali. Nonostante queste critiche, molti lettori considerano il libro stimolante e attuale rispetto alle sfide ambientali odierne.
Civilizations Rise and Fall Series
Similar Books