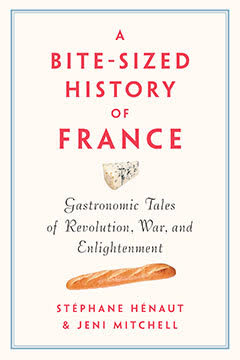Punti chiave
1. Cibo francese: un bizzarro connubio di sublime e assurdo
Se c’è una cosa che emerge con chiarezza nella storia senza fine della Francia, è la facile convivenza tra il sublime e l’assurdo.
Un carattere affascinante. La Francia, celebre per il suo fascino e il suo spirito illuminato, spesso lascia perplessi i visitatori con le sue usanze, la politica e le abitudini gastronomiche tanto bizzarre quanto uniche. Questo mix di maestoso e mutevole, di glorioso e infernale, definisce il suo carattere irresistibile. Gli autori, un formaggiaio francese e uno studente americano, lo hanno scoperto addentrandosi nel pungente mondo dei formaggi francesi, dove ogni “formaggio puzzolente” racconta una storia ricca e coinvolgente.
Il cibo come identità. L’identità francese è profondamente intrecciata con le sue tradizioni alimentari — le consuetudini legate al mangiare, bere, coltivare e allevare la vite. Questo si riflette nelle espressioni quotidiane e nel discorso politico:
- “Triste come un giorno senza pane” (sad comme un jour sans pain)
- La sfida di De Gaulle: “Come si può governare una nazione che ha 246 varietà di formaggio?”
- I contadini che protestano contro le norme europee, viste come una minaccia alla vita tradizionale.
- I politici di estrema destra che usano il cibo (maiale, vino) per definire la “francesità” contro le comunità musulmane.
Un amalgama globale. Nonostante le rivendicazioni nazionaliste di una cucina francese “pura”, la sua gastronomia è un ricco amalgama di sapori e usanze provenienti da tutto il mondo. Vigneti romani, pasticceria austriaca, caffè turco, cioccolato messicano e pomodori americani dimostrano che la cucina francese è un blend internazionale in continua evoluzione, rendendo ridicole le pretese di una tradizione immutabile e incontaminata.
2. Radici antiche: Galli, Romani e la nascita del vino
La maggior parte dei francesi concorderebbe con François Rabelais, il grande umanista rinascimentale, che affermava: “dal vino si diventa divini”.
Origini straniere del vino. Venticinquecento anni fa il vino era quasi sconosciuto in Gallia, dove si preferiva la cervoise, una birra fermentata d’orzo. I ricchi Galli stupivano i Romani bevendo vino italiano importato, puro e in eccesso, concedendo persino alle donne pari diritti nel bere. La coltivazione della vite era limitata a Marsiglia, fondata dai Greci.
Conquista romana e fusione culturale. I Romani, che inizialmente consideravano i Galli “barbari chiassosi, ubriachi e incivili”, conquistarono la Gallia nel 52 a.C., dando vita all’epoca “gallo-romana”, un mix culturale che influenzò:
- La lingua: Il francese moderno affonda le radici in questa fusione.
- Le abitudini alimentari: I Galli adottarono il consumo di vino e la coltivazione della vite.
- I vigneti: Nuovi vigneti sorsero in Borgogna, Alsazia, Bordeaux, producendo vini apprezzati persino a Roma.
La botte di legno. Nonostante la supremazia romana, furono i Galli a inventare la botte di legno, inizialmente per la cervoise e poi per il trasporto di cibo. Questa innovazione, superiore alle anfore romane, è fondamentale per l’invecchiamento di vini, cognac e whisky, conferendo aromi pregiati. Anche l’aceto balsamico deve la sua forma attuale alle botti galliche.
3. Cibo feudale: un segno di classe e potere
Una tavola nobiliare appariva molto diversa, non solo per la quantità abbondante di cibo offerto (un modo semplice per mostrare ricchezza e potere).
L’ascesa del feudalesimo. L’anarchia dei secoli IX e X, segnata da guerre e invasioni continue, portò all’affermazione dei signori locali e al sistema feudale. I re concedevano terre (feudi) in cambio di fedeltà e servizio militare, creando una piramide sociale: re, grandi signori, signori minori e, in fondo, i contadini (90% della popolazione), per lo più servi della gleba legati alla terra.
Diete basate sulla classe sociale. Il cibo divenne un rigido indicatore di classe, giustificando il dominio della nobiltà.
- Dieta contadina: Dominata da cereali (segale, orzo, avena), ortaggi da orti esenti da tasse (porri, cipolle), occasionalmente maiale, uova, formaggio e abbondante vino, sidro o birra (più sicuri dell’acqua).
- Dieta nobiliare: Abbondante, con enfasi su carni arrosto (vicine al “fuoco”, l’elemento più nobile), selvaggina (caccia, attività guerriera) e volatili. Evitavano le radici (legate alla “terra”, elemento spregevole) e le carni bollite.
Il droit de ban e il Ban des Vendanges. I signori esercitavano il droit de ban, imponendo tasse e obbligando i contadini a usare i loro mulini o torchietti per il vino. Questo includeva il Ban des Vendanges, la data ufficiale per la vendemmia, garantendo riscossione delle tasse e controllo della qualità. Questo sistema, pur vantaggioso per i potenti, alimentava rivolte contadine.
4. Innovazioni monastiche: monaci, formaggi e vino
Poiché il formaggio può avere note di gusto diverse, dal floreale e fruttato al pungente e carnoso, sembra che i monaci non ne avessero mai abbastanza, diventando esperti casari.
I monasteri come centri culinari. I monaci medievali, proibiti dalla carne ma autorizzati al latte, divennero maestri nella produzione di formaggi classici come Munster, Abondance ed Époisses. La severa Regola benedettina, pur rigorosa, permetteva creatività nel cibo, soprattutto nell’allevamento di pesci e nella produzione di vino. Monasteri in Borgogna trasformarono varietà locali in vini di fama mondiale come lo Chablis.
Ascetismo e gastronomia. L’ordine cistercense, fondato nel XII secolo, cercava una vita più ascetica, vietando uova, pesce, formaggio e latte. Tuttavia, la loro dedizione al lavoro manuale in agricoltura, soprattutto nella viticoltura, portò a contributi gastronomici significativi. Il loro lavoro meticoloso nei vigneti di Borgogna, come il Clos de Vougeot, perfezionò le tecniche di vinificazione.
Ricchezza, filantropia e influenza. I monasteri accumularono immense ricchezze grazie a donazioni, diventando grandi proprietari terrieri e signori feudali. Questa ricchezza permise loro di essere filantropi, offrendo cibo e rifugio ai poveri e promuovendo alfabetizzazione e cultura. L’immagine del “monaco ricco e grasso” aveva fondamento, dando origine a nuovi ordini dedicati ai poveri come domenicani e francescani.
5. Rinascimento e conquista: nuovi sapori da lontano
Nessun individuo incarna meglio quest’epoca di trasformazione di Leonardo da Vinci, uomo di talenti straordinari e molteplici.
Il Rinascimento francese nella Loira. Il XV e XVI secolo segnarono la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna, caratterizzata da progresso umano e sfida ai dogmi. L’invasione italiana di Carlo VIII nel 1494, pur limitata militarmente, portò artigiani, architetti e giardinieri italiani in Francia, soprattutto nella valle della Loira, dando il via al Rinascimento francese. Leonardo da Vinci trascorse gli ultimi anni ad Amboise, invitato da Francesco I.
Nuovi cibi e gusti reali. Le influenze italiane introdussero nuovi alimenti e stili di cucina alla corte francese.
- Arance: Fiorite per la prima volta in Francia ad Amboise, con la costruzione di elaborate orangerie per la coltivazione tutto l’anno.
- Prugne: La regina Claudia, moglie di Francesco I, rese popolare la succosa prugna Reine-Claude.
- Confetteria: Spezie candite, frutta, gelatine e conserve divennero di moda, con lo zucchero che assunse il ruolo di nuovo simbolo di status.
L’eredità culinaria di Caterina de’ Medici. Caterina, moglie di Enrico II, è spesso accreditata per aver trasformato la cucina francese introducendo chef italiani e alimenti come broccoli, carciofi e fagioli. La sua influenza spostò i gusti nobiliari verso le verdure, superando le avversioni medievali, dando origine a piatti “alla fiorentina” (es. uova alla fiorentina).
6. Le salse madri: una rivoluzione culinaria
La salsa (n.): il segno infallibile di civiltà e illuminazione. Un popolo senza salse ha mille vizi; un popolo con una salsa ne ha solo novecentonovantanove.
Dalle salse medievali a quelle moderne. Le salse medievali francesi erano fortemente speziate e acide, basate su aceto, limoni e verjus (succo d’uva acerba), raramente contenevano grassi. Nel XVII secolo avvenne una rivoluzione culinaria:
- Grassi: Burro e olio divennero protagonisti, sostituendo gran parte dell’acidità.
- Erbe locali: Erba cipollina, aglio, scalogno e funghi presero il posto delle spezie esotiche.
- Filosofia: Emersero idee radicali: “il cibo deve avere il sapore di ciò che è”, promuovendo sapori più semplici e naturali.
La codifica di Carême. All’inizio del XIX secolo, il leggendario chef Marie-Antonin Carême portò ordine nelle salse francesi, identificando quattro “salse madri” da cui derivano tutte le altre: allemande, béchamel, espagnole e velouté. Queste salse a base di roux permettevano infinite varianti “figlie”, studiate per accompagnare piatti specifici.
L’aggiornamento di Escoffier e la maionese. Nel XX secolo, Auguste Escoffier aggiornò la lista a cinque salse madri, aggiungendo hollandaise e salsa di pomodoro. I francesi sono anche famosi per la maionese, salsa a base di olio, presumibilmente inventata nel 1756 dopo la conquista francese di Mahón, quando un cuoco sostituì la panna con l’olio d’oliva.
7. Dolce amaro: zucchero, schiavitù e colonialismo
Tante lacrime sono state versate per lo zucchero che, a ragione, avrebbe dovuto perdere la sua dolcezza.
Il viaggio globale dello zucchero. La canna da zucchero, originaria del Sud-Est asiatico, si diffuse verso ovest attraverso commercio e conquiste, diventando un’industria redditizia in Medio Oriente e poi in Europa. La colonizzazione europea aprì vasti territori nelle Americhe, dando vita a immense piantagioni di canna nei Caraibi e in Brasile.
La tratta atlantica degli schiavi. La coltivazione intensiva della canna spinse le potenze europee, Francia inclusa, a ricorrere alla tratta degli schiavi africani. Navi dai porti francesi come Nantes trasportavano schiavi in America, tornando con zucchero, caffè e rum. Nantes divenne il porto schiavista più importante di Francia, la sua prosperità fondata su questo commercio barbaro.
Eredità coloniale e consumo moderno. Il gâteau nantais, torta alla vaniglia imbevuta di rum, è un’eredità culinaria diretta della ricchezza derivata dalla tratta degli schiavi di Nantes. Pur riconoscendo tardivamente questo passato amaro, la storia dello zucchero mostra come il cibo sia spesso legato allo sfruttamento. Oggi la maggior parte dello zucchero francese proviene dalla barbabietola, sviluppo favorito dai blocchi delle guerre napoleoniche.
8. Scienza e sopravvivenza: guerra, patate e conservazione
Monsieur Appert ha scoperto l’arte di fissare le stagioni: nella sua casa primavera, estate e autunno vivono in bottiglia, simili a quelle delicate piante che il giardiniere protegge sotto campane di vetro contro le stagioni inclementi.
La sfida alimentare di Napoleone. Napoleone sapeva che “un esercito marcia sullo stomaco”, dando priorità a nuovi metodi di conservazione per la sua Grande Armata. Il Direttorio offrì un premio per soluzioni alla scarsità di cibo, attirando l’attenzione di Nicolas Appert.
L’invenzione rivoluzionaria di Appert. Appert, pasticcere, sviluppò “l’appertizzazione” — conservare il cibo in bottiglie ermeticamente chiuse e bollite. Questo processo, poi compreso da Louis Pasteur come sterilizzazione, rivoluzionò la produzione alimentare permettendo la conservazione per anni, indipendentemente da stagione o luogo.
- Prima applicazione: Piselli verdi offerti a dicembre, stupirono gli ospiti.
- Impatto: Eliminò la scarsità alimentare, aiutò i marinai (contro lo scorbuto) e stimolò nuove industrie alimentari.
- Eredità: Appert è considerato il padre delle conserve, anche se gli inglesi adattarono il metodo alle lattine di latta.
Il propagandista della patata. Antoine-Augustin Parmentier, farmacista dell’esercito francese, promosse la patata, originaria del Sud America e inizialmente rifiutata in Europa per paure di lebbra e natura “non biblica”.
- Appoggio reale: Luigi XVI e Maria Antonietta indossavano fiori di patata, rendendoli di moda.
- Cibo rivoluzionario: Il governo rivoluzionario promosse la patata per combattere la fame e prevenire accaparramenti, distribuendo i memorie di Parmentier e La Cuisinière républicaine di Madame Mérigot (il primo ricettario francese scritto da una donna, interamente dedicato alla patata).
- Eredità duratura: La patata divenne un alimento base francese, celebrata in piatti come l’hachis Parmentier e persino nella stazione Parmentier della metropolitana di Parigi.
9. La maledizione della fata verde: alcol, guerra e identità
Sono per il vino e contro l’assenzio, come sono per la tradizione e contro la rivoluzione.
Ascesa e declino dell’assenzio. L’assenzio, la “fata verde”, liquore svizzero all’anice, divenne popolare in Francia nel XIX secolo. I soldati francesi in Algeria lo usavano per purificare l’acqua, e divenne un aperitivo di moda nell’“ora verde” parigina. Artisti e scrittori bohémien lo abbracciarono, credendo stimolasse la creatività, nonostante la sua fama di causare follia per l’alto contenuto alcolico e la distillazione approssimativa.
Crisi della fillossera e temperanza. La fillossera, un insetto americano, devastò i vigneti francesi alla fine del XIX secolo, facendo crollare la produzione di vino. Questa crisi, unita all’aumento dell’alcolismo, portò a un’alleanza tra produttori di vino e movimento temperanza. Questi ultimi attaccarono gli “alcoli industriali”, soprattutto l’assenzio, come causa dei mali sociali, promuovendo il vino come “alcol naturale”.
Divieto bellico e rinascita moderna. Nel 1914, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il governo francese vietò l’assenzio, ritenendolo un fattore di indebolimento nazionale. Il vino, invece, rimase razionato ai soldati. Dopo la guerra, le distillerie di Pontarlier si convertirono al pastis, alternativa all’anice. Il divieto fu revocato nel 2010 e l’assenzio fece il suo ritorno.
10. L’eredità dell’impero: couscous e assimilazione culturale
La Francia è diventata il maggior consumatore europeo di couscous, e i sondaggi indicano che è ora il terzo piatto preferito dai francesi (dopo magret de canard e moules-frites).
L’influenza maghrebina di Marsiglia. Marsiglia
Ultimo aggiornamento:
Recensioni
Una Storia Compatta della Francia ha ricevuto recensioni per lo più positive grazie al suo coinvolgente connubio tra storia francese e gastronomia. I lettori apprezzano i capitoli brevi, le curiosità interessanti e uno stile di scrittura accessibile. Molti l’hanno trovato sia informativo che piacevole, lodando il modo in cui il cibo viene collegato agli eventi storici. Alcuni critici, invece, hanno ritenuto che il testo fosse troppo politicizzato o critico nei confronti della Chiesa cattolica. Nel complesso, la maggior parte delle recensioni lo consiglia agli appassionati di storia, agli amanti della buona cucina e ai francofili, anche se qualche sezione è risultata meno coinvolgente. Il libro ha lasciato molti lettori con la voglia di assaporare la cucina francese e di scoprire il paese.